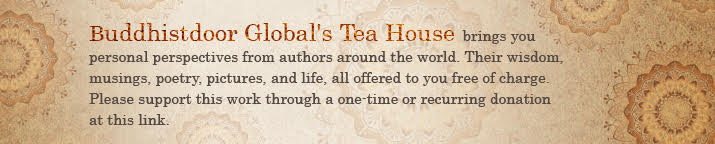Edizione originale in lingua inglese
Traduzione italiana a cura di Costanza Ceccarelli
© Āgama Research Group

Buddhistdoor Global (BDG): Venerabile, potrebbe descriverci il tema e le idee generali esposti nel suo intervento al convegno?
Bhikkhunī Dhammadinnā (BD): Il mio intervento si occupa di esaminare come i concetti di esperienza e di costruzione condizionata dell’identità e della presunzione del sé – letti attraverso il prisma degli insegnamenti del buddhismo antico e trasmessi nei discorsi antichi – possono comunicare ed entrare in dialogo con l’approccio postmoderno che mette in primo piano l’esperienza vissuta, profondamente sentita, della persona o del conoscitore come un assoluto epistemico.
La conoscenza liberatrice del Buddha, il risveglio del Buddha, secondo quanto riferito, sono il risultato dell’aver penetrato il modo in cui si costruisce l’esperienza condizionata che si traduce nella costruzione dell’identità (in breve, il nostro ego) e nell’identificazione con tale processo. Esperienza condiziona da cosa? Dalla brama (taṇhā in pali, tṛṣṇā in sanscrito) e dall’ignoranza (avijjā in Pali, avidyā in sanscrito). Avendo penetrato il modo in cui le esperienze condizionate e la costruzione dell’identità sono poste in essere dall’attività combinata della brama e dell’ignoranza, secondo i discorsi antichi, il Buddha è stato in grado di comprendere come viene in essere l’esperienza condizionata e come si arriva ad identificarsi col proprio senso di identità. Abbiamo la costruzione dell’esperienza, che è un fatto cognitivo, e, a seguire, l’ulteriore identificazione con essa come costrutto identitario, che è un altro strato autoreferenziale sorto condizionatamente nel momento presente.
Come ha spiegato la bhikkhunī arahant Dhammadinnā (sì, sono la sua omonima) in una memorabile esposizione, nell’insegnamento del Buddha sono i cosiddetti cinque aggregati dell’attaccamento (pali upādānakkhandha, sanscrito upādānaskandha) ad essere considerati come ‘identità’. Tali cinque sono la forma corporea, il tono affettivo, l’identificazione concettuale, le formazioni volitive e la coscienza. Questi stanno per il ‘dove’, il ‘come’, il ‘cosa’, il ‘per che cosa’ e il ‘chi’ dell’esperienza soggettiva. Il sorgere del costrutto identitario è dovuto al diletto e all’attaccamento in relazione al divenire futuro – cioè, la continuazione di tale esperienza – congiunto alla brama che si assapora qua e là. La cessazione di tale aggregato identitario così costruito si realizza attraverso la rimozione del diletto e dell’attaccamento in relazione al divenire e alla brama futuri, attraverso la loro completa rinuncia, il loro completo esaurirsi, scolorirsi, cessare e pacificarsi. La cessazione ha luogo attraverso la conoscenza penetrante (nel senso di visione penetrante liberatrice), cosicché, affinché si dia tale tipo di ‘conoscenza’, bisogna prendere congedo da ogni attaccamento ed identificazione con l’esperienza (qui definita attraverso i cinque aggregati dell’attaccamento). Tale conoscenza è, per definizione, ‘slegata’ dall’identità, poiché si dà attraverso il venir meno del costrutto identitario.
La conoscenza di cui sto parlando è soteriologica, soteriologicamente rilevante e orientata in tutto. È il tipo di conoscenza interiore trasmessa dall’idea della liberazione del Buddha, che raffigura la totale emancipazione dalle contaminazioni. Il tipo di conoscenza, cioè, rilevante affinché gli altri possano ottenere quella stessa condizione interiore, in linea con tale fine.
Quello che ho definito come assoluto epistemico postmoderno, invece, si basa sull’assunto che la conoscenza sia intrinsecamente legata al costrutto identitario. Conseguentemente, questo assunto abbraccia le teorie della posizionalità (positionality) e dello standpoint (punto di vista) come valide basi teoretiche e pratiche per l’educazione personale e pubblica, o per la propria crescita. Questi assunti stanno permeando sempre di più il discorso buddhista contemporaneo. E questo non accadde soltanto a livello dello studio accademico del buddhismo, ma anche nella pratica, nella pratica del Dharma, nelle comunità buddhiste.
BDG: Potrebbe dirci di più sulle teorie della posizionalità (positionality) e dello standpoint?
Questa rinegoziazione postmoderna dell’identità e dell’identificazione è molto interessante, poiché eleva lo status epistemico dell’esperienza personale, così come essa viene plasmata dalle specificità e dalle idiosincrasie dell’esperienza vissuta dei diversi gruppi identitari, che sono posizionati in modo diverso nella società e quindi ne vedono aspetti diversi. C’è uno scetticismo radicale nei confronti dell’idea che la conoscenza possa essere oggettiva ed universale. Questo porta al convincimento che la base legittima della conoscenza non sia la metodologia con cui si raggiunge l’evidenza, ma piuttosto i ‘punti di vista’ basati sul costrutto identitario e le molteplici ‘modalità di conoscenza’. Il valore di questi non dipende dal vedere come si costruisce il costrutto identitario, quanto piuttosto dal genere, dalla razza, dal sesso, dalla geografia, dalla condizione sociale e così via.
L’idea è che la propria identità e posizione all’interno della società convalidi il modo attraverso cui si giunge alla conoscenza. La conoscenza, dunque, è sempre ‘situata’, cioè si dà come risultante del proprio particolare ‘punto di vista’ – interno, esterno e interno-esterno o relazionale – nella società. Nello specifico, con interno, esterno e interno-esterno, mi riferisco qui alle tre dimensioni fondamentali dell’esperienza soggettiva, come enunciato negli insegnamenti buddhisti antichi sulla presenza mentale: me stesso (internamente), l’altro o gli altri (esternamente) e il campo relazionale sé-altro (internamente-esternamente). La presenza mentale può essere stabilità in relazione a tutte e tre le dimensioni; la sua applicazione a tutte e tre le dimensioni insieme sviluppa il potenziale più efficace per la trasformazione individuale e sociale.
Spesso ciò equivale alla propria appartenenza a gruppi identitari che si intersecano tra di loro. Il risultato netto è la non disponibilità di alcuna verità oggettiva e l’inevitabile legame della conoscenza al costrutto identitario. Costrutto che, a sua volta, è plasmato dal potere sociale e ideologico (o dalla sua mancanza o dagli sforzi per affermarlo). Di conseguenza, la stessa conoscenza è legata alla dialettica che l’interazione tra conoscenza e potere vengono a co-creare (cioè, a quale gruppo(i) appartengo e la sua posizione sociale in relazione al potere epistemico). Nel discorso in esame, ad esempio, appartenere ad una minoranza o ad un gruppo emarginato garantisce un accesso privilegiato alla verità, in virtù del fatto che tale posizione dà alla persona una capacità epistemica esclusiva, senza che rimanga molto spazio per le categorie di universalità e di individualità che attraverso i secoli hanno plasmato l’umanità collettivamente. In questo modo, dalla prospettiva del buddhismo antico, la conoscenza si lega inevitabilmente alla mia esperienza dei cinque aggregati dell’attaccamento. Aggregati che, tuttavia, sono essi stessi pregiudizievoli, a causa della presenza stessa dell’attaccamento e dell’investimento identitario su di essi attraverso il loro godimento e, dunque, sorge una presunzione di/dei sé.
La fallacia logica della teoria dello standpoint è ovvia: essa presuppone che individui che abitano le stesse identità, costruite sulle loro posizioni sociali (razza, età, abilità di genere, sesso, orientamento sessuale, o salute), debbano condividere le medesime esperienze soggettive dell’essere nel mondo in termini di posizioni di dominio o di oppressione, a condizione di essere sufficientemente e correttamente capaci di comprenderle. (Occupare più di una di tali posizioni è definito ‘intersezionalità’.) Tali posizionamenti portano intrinsecamente a interpretare l’esperienza personale più o meno nello stesso modo (nella misura in cui la persona è consapevole della propria posizione). Queste esperienze presumibilmente mi forniscono un quadro (o l’unico) più completo e intrinsecamente autorevole. Ne deriva che il proprio posizionamento determina ciò che può essere conosciuto e da chi e ciò che non può essere conosciuto da chi. Tipicamente, viene assegnata una superiorità epistemica a coloro che sono socialmente svantaggiati e oppressi, superiorità fondata sulla loro comprensione sia della propria posizione che delle dinamiche di potere che la generano, mentre a coloro che sono socialmente privilegiati e dominanti viene assegnato un posto di inferiorità epistemica, attribuita alla loro incapacità nel saper cogliere la parzialità del privilegio che vivono e della vita degli oppressi.
Per mia parte – come monaca europea pienamente ordinata (bhikkhunī), il cui stesso ‘diritto di esistere’ è messo in discussione da un’ampia sezione dell’istituzione monastica Theravāda e che senza dubbio subisce discriminazioni a causa dell’androcentrismo istituzionale e della misoginia ascetica che sussiste tra le altre ideologie – non credo, né sento, che la mia situazione esistenziale sia per definizione inaccessibile ad altri esseri umani che non condividono esattamente la stessa ‘esperienza’ di ‘me’. Potrei, in effetti, sommare diversi livelli per caratterizzare la ‘intersezionalità’ della mia esperienza soggettiva e la discriminazione con cui devo confrontarmi quando mi trovo in contesti diversi. Ma non mi riconosco in una o più definizioni dipendenti dai contorni di tale situazione, né desidero essere considerata sulla base di questa, per non parlare di essere ridotta alla stessa o di esservi epistemicamente ed esistenzialmente imprigionata. E dobbiamo assolutamente evitare di restringere il nostro spazio al punto da finire con il concentrarci egoisticamente sul senso sentito delle nostre difficoltà e perdere la capacità di fare spazio all’altro.
Ora, per non essere fraintesa, c’è davvero un urgente bisogno di sostenere e dare potere a coloro che sono socialmente svantaggiati e oppressi, così come c’è un bisogno altrettanto urgente che coloro che sono socialmente privilegiati e dominanti diventino consapevoli dei loro privilegi e modelli di dominio. Pure, se portati all’estremo, ho la sensazione che questi orientamenti ci rendano prigionieri del costrutto identitario, piuttosto che capaci di comprenderlo. E che dire della presunta ‘fluidità’ epistemica che si suppone possa essere esibita nella capacità di ridefinire costantemente le mie molte identità e posizioni personali, che dire delle politiche identitarie che apprezziamo come un’altra funzione performativa di costruzione dell’identità in cui troviamo diletto? In questo modo, divento inevitabilmente più legato alla mia esperienza dei cinque aggregati dell’attaccamento e li alimento con ulteriore materia prima. Tali aggregati sono pregiudizievoli, proprio a causa della presenza dell’attaccamento e dell’investimento identitario che su di essi si agisce, in primo luogo, attraverso il godimento. Dalla prospettiva del buddhismo antico, tutto ciò non mi può portare avanti sul cammino della liberazione dalle contaminazioni.
Per il Buddha la dimensione fondamentale dell’esperienza è rappresentata dal contatto attraverso le sei basi dei sensi (pali phassa, sanscrito sparśa), come ‘punti di vista’ o ‘basi’ (pali vatthu, sanscrito vastu) per la creazione di punti di vista di sé, comprese le alte conquiste meditative, le posizioni cosmologiche e filosofiche. Il contatto non è altro che la base per il sorgere dell’esperienza personale. Individuando anche la più nuda forma di esperienza (il contatto seguito dal tono affettivo, vedanā) come ciò che porta al sorgere di un punto di vista e come ciò che è responsabile del sorgere della autoposizionalità, gli insegnamenti antichi buddhisti non incoraggiano certo il perseguimento della teoria dello standpoint.
BDG: Perciò è corretto affermare che il Buddha ha qualcosa da dire riguardo la soggettività, dal momento che ha insegnato l’esperienza dello smantellamento del costrutto identitario e dell’identificazione con tale costrutto?
BD: È un atto radicale di decostruzione del costrutto identitario. Come descritto nei discorsi antichi, per il Buddha noi abbiamo la potenzialità per arrivare a una valutazione della nostra esperienza soggettiva su un terreno oggettivo. Quindi, secondo gli insegnamenti del buddhismo antico, si dà assolutamente priorità all’esperienza in prima persona e, allo stesso tempo, si dà la possibilità di comprendere l’esperienza in prima persona, soggettiva, in un modo più ‘oggettivo’.
Perché più ‘oggettivo’? Perché non è più ‘reificato’ su base autoreferenziale in forza della brama e dell’ignoranza. Quando smetto di reificare la mia esperienza e di identificarmi con essa, diviene possibile una conoscenza più oggettiva del modo in cui viene in essere la mia esperienza soggettiva. Questo va contro l’idea che la ‘esperienza vissuta’ sia unica e inaccessibile a persone dal diverso ‘costrutto identitario’. Portata all’estremo, quest’ultima posizione comporta che la scoperta del Buddha della causa del dukkha (pali; sanscrito duḥkha) esistenziale come verità valida per tutti gli esseri divenga senza senso e che il sentiero di emancipazione dal dukkha sia inapplicabile. Un punto, questo, piuttosto importante.
Poiché da parte del Buddha c’è sicuramente un atto di verità e una asserzione di verità basati sull’esperienza in prima persona, penso che ad ognuno possa darsi la possibilità di arrivare alla stessa esperienza della verità in relazione alla propria esperienza in prima persona, seguendo il sentiero buddista antico dell’emancipazione. Questa emancipazione è libertà dalla brama e dall’ignoranza, che creano i pregiudizi cognitivi, emotivi ed etici (a causa dei quali viene fraintesa l’esperienza in prima persona).
C’è questa costante interazione tra l’esperienza in prima persona e la possibilità che la stessa sia verificata dall’esperienza in terza persona di qualcun altro nella propria esperienza in prima persona. Quindi, negli insegnamenti del Buddha, si dà sicuramente assoluta priorità all’esperienza soggettiva.
BDG: Quindi, come è trasmessa questa nozione di esperienza liberata nei discorsi antichi?
BD: In sostanza, siamo rimasti con la stessa terminologia usata nei discorsi buddisti antichi per descrivere l’esperienza soggettiva (āyatana, che sta per dominio dell’esperienza o base ‘esperienza, o sfera d’esperienza; e contatto, sparśa in sanscrito, phassa in pali, che indica il contatto per mezzo delle sei basi sensoriali).
Prendiamo in considerazione, ad esempio, l’esperienza del nirvana, descritto come un āyatana, cioè come un dominio o una sfera esperienziale. Si dice che è possibile contattare la cessazione dell’esperienza, contattare in maniera esperienziale il Nirvāṇa col proprio essere. Questo mostra che, una volta adempiuto il compito di decostruire l’esperienza costruita (circa 2500 anni fa!), non si è sentito il bisogno di porre in essere un nuovo discorso per istituire un linguaggio ad hoc per questo nuovo dominio dell’esperienza liberata.
Il Buddha evidentemente non propone qui una nuova retorica dell’esperienza personale. Neppure la forma più alta di esperienza diretta personale – l’esperienza del pieno risveglio o Nirvāṇa (che fondamentalmente corrisponde ad una esperienza della cessazione della soggettività costruita) – necessita di un intero nuovo corredo terminologico per dare conto di queste esperienze di emancipazione dall’esperienza condizionata.
Vediamo che il Buddha non mostra di avere problema alcuno ad usare il pronome di prima persona nei suoi discorsi. Quando descrive la ricapitolazione le sue vite passate, usa la prima persona: ‘io’ avevo il nome tal dei tali, ‘io’ ero nato in tale clan, o, di nuovo in prima persona, ‘io’ ho raggiunto l’insuperabile perfetto risveglio, sono uno che è divenuto calmo, estinto, ho compreso tutto ciò, e così via.
Si dice che anche I primi arahant buddhisti si esprimessero allo stesso modo. Per esempio, la monaca pienamente risvegliata Kisā Gotamī si riferisce a sé stessa dicendo ‘io sono’: ‘Io sono una che ha rimosso il dardo, ha deposto il fardello e ha fatto ciò che doveva essere fatto’. La differenza cruciale è che questi termini autoreferenziali, come ‘io’ o ‘mio’, vengono utilizzati per riferirsi ad un’esperienza soggettiva completamente liberata e libera. Questo non confligge con l’insegnamento del non-sé dell’anattā o con il vuoto. Piuttosto, grazie alla piena realizzazione del non-sé e del vuoto o vacuità, quegli stessi termini possono essere utilizzati con leggerezza, senza alcuna reificazione e senza alcuna parzialità o attaccamento.
BDG: Perché il Buddha e gli esseri pienamente risvegliati possono parlare in prima persona senza alcun rischio di fraintendimento o di rappresentazione parziale?
BD: Perché hanno sradicato la presunzione del sé (pali e sanscrito māna), le concezioni, le immaginazioni, il meccanismo di costruzione delle immagini di sé e ogni riferimento al sé, ogni autoreferenzialità. Hanno superato tutte queste possibilità di autoposizionamento nei confronti della realtà sotto l’effetto della brama e dell’ignoranza. Di tutto questo non rimane niente, quindi linguaggio ed esperienza in prima persona sono liberi, assolutamente liberi, dall’ignoranza e dalla brama. Non c’è alcun problema dal punto di vista epistemologico e il linguaggio può essere utilizzato in una maniera molto fluida. Non c’è più alcun ‘sé’ da assumere, per così dire.
Māna è la presunzione di fondo, l’idea di ‘io sono’ pervasa dalla brama. In sostanza, la presunzione è uguale alla nozione ‘io sono’ (asmī ti mānagatam etaṃ). Quindi, questo stesso senso della nozione ‘io sono’ sta per presunzione di sé. Pure, non c’è problema alcuno nel dire io sono questo o io sono quello, parlando in prima persona, o parlando di altri in terza persona, perché una volta che questa relazione problematica col linguaggio, con le convenzioni, con la realtà così com’è, è stata risolta, non c’è più bisogno di problematizzare il linguaggio. Non c’è bisogno di problematizzare l’esperienza in prima persona, i pronomi e così via. Non c’è bisogno di aspirare ad espressioni perfette che rendano conto delle molte diverse sfaccettature della propria esperienza personale, perché, semplicemente, non ci si identifica più con l’esperienza.
Questo è molto diverso dall’idea che è talvolta circolata tra I buddhisti contemporanei, per cui si deve quasi aver paura di usare affermazioni in prima persona in relazione alla propria pratica spirituale o in relazione ad altri ambiti d’esperienza.
Sentiamo espressioni del tipo: “sai, questo è solo un modo dire, questa è solo la realtà convenzionale, ma, dal punto di vista della realtà ultima, non si dovrebbero usare queste coniugazioni, questo tipo di linguaggio, perché esso non rende conto del fatto che l’esperienza è un processo e non un sé”. Ho incontrato anche praticanti che si sforzavano di flettere qualsiasi cosa avessero da dire riguardo a se stessi in forme impersonali, usando forme verbali che denotassero processi, o che sentivano ogni volta il bisogno di mettere ‘io’ (dico, penso, do, ricevo … eccetera) tra virgolette, come se non fosse legittimo fare affermazioni in prima persona per un vero praticante della visione penetrante buddhista.
Assai interessante, il Buddha e tutti gli esseri pienamente risvegliati non sentirono il bisogno di problematizzare questo livello ordinario di esperienza. Quindi non c’è problema nel dire ‘io sono questo’ e ‘io sono quello’, nella misura in cui non sto assumendo una posizione non salutare in relazione a questa esperienza.
BDG: Alla luce di questa visione penetrante, cosa si può dire del dibattito postmoderno sulla produzione di significati come: auto-significarsi, significare l‘altro, significato interno, significato esterno, significato interno-esterno? Cosa possiamo dire della continua riprogettazione e del continuo riposizionamento della propria esperienza?
BD: Possiamo dire che la propria identità diviene un luogo di identificazione e di posizionamento. La meccanica del costante cambiamento sociale, della costante reinvenzione delle identità di genere, della costante reinvenzione delle affiliazioni al lignaggio, alla razza e di tutti i possibili aspetti che mi auto-definiscono nel mondo, questo costante abbracciare uno o più aspetti ‘intersezionali’ dell’esperienza come un aspetto cruciale, come un segno cruciale, come una causa cruciale per l’affermazione della mia percezione di me stesso e del mio posizionamento nel mondo: questi stessi meccanismi diventano il nucleo essenzializzato dell’autoposizionalità, dell’autoconcepimento e dell’identità di sé come autoidentificazione.
Al punto che, a meno che io non sia, ad esempio, un membro di un certo gruppo affine o non sia nella posizione di condividere un particolare senso di identità di genere (o anche di più di una identità) o che altro, io non sono in grado di accedere alla verità, alla verità esperienziale soggettiva di coloro che invece condividono quelle particolari configurazioni.
Qui, naturalmente, sto semplificando. Sono totalmente favorevole a rispettare e a dare voce alle esperienze discriminate e sotto-rappresentate, alle nostre vite vissute(la mia inclusa). Tuttavia, ciò che tende a succedere è che si viene a minare la possibilità stessa di un terreno comune, di un comune senso condiviso di arrivare alla verità.
Il ‘programma buddhista’, il programma sulla soggettività del buddhismo antico, riguarda esattamente il fatto che condivido con te e con gli altri il fatto stesso dell’esperienza soggettiva. Condividiamo anche l’impatto della nostra soggettività sulla nostra esperienza, che, a sua volta, è un fenomeno sorto in dipendenza. Ecco, allora, che posso condividere con gli altri la pratica degli insegnamenti buddhisti che mi aiutano a decostruire la soggettività, la pratica della comprensione di come costruisco la mia propria esperienza nella morsa della cupidigia (rāga), dell’avversione (pali dosa, sanscrito dveṣa) e dell’illusione (moha) e di come posso evitare di costruirla su tali fondamenta non salutari.
Con l’aiuto di questa inquadratura, posso vedermi ancora in possesso di cupidigia, avversione e illusione, ma mentre lavoro verso la purificazione del cuore, e posso considerare tutti gli altri dallo stesso punto di vista, piuttosto che lottare per affermare il mio (potenzialmente illusorio) punto di vista sulla realtà interna ed esterna. Punto di vista che, molto probabilmente, è fallace, in quanto condizionato ed effettivamente modellato dalla presenza di condizioni non salutari nella mente. Perciò lavoriamo per la emancipazione dal costruire, per la emancipazione dai pregiudizi. Stiamo condividendo l’esperienza e la nostra pratica per capire come la costruiamo.
BDG: Dunque, approcciamo un’esperienza della realtà così com’è?
BD: Sì, in termini buddhisti, questo è definito ‘esperienza della realtà in corrispondenza con la realtà’. La possibilità, cioè, di pervenire ad una conoscenza effettiva proprio attraverso la comprensione di come costruiamo la conoscenza parziale. Questo è molto importante. Il culmine del risveglio del Buddha è il concetto di conoscenza e visione in accordo con la realtà o secondo realtà, con il mondo in cui le cose sono venute in essere (yathābhūta). Nel suo fondamentale libro sull’epistemologia buddhista (Early Buddhist Theory of Knowledge, 1963), il Prof. K. N. Jayatilleke ha definito ciò come una ‘teoria della corrispondenza della realtà’. A voler dire che la verità o la falsità di una affermazione si misura in base a quanto quest’ultima sia coerente con la realtà effettiva o la contraddica.
La realtà effettiva in questione è quella della mia esperienza personale, soggettiva. Perciò, è assolutamente possibile pervenire ad una conoscenza e ad una visione dirette in prima persona della realtà effettiva della mia esperienza presente come essa sorge nel momento presente, senza doverla innalzare ad una forma di presunzione, māna. Perché questo è esattamente ciò che fa una mente ignorante non risvegliata, cioè innalzare l’esperienza condizionata della realtà, l’esperienza parziale, allo status di un assoluto epistemico. Ed è ciò che ordinariamente facciamo in tutte le nostre interazioni non risvegliate col mondo.
BDG: Come si traduce tutto ciò nella pratica effettiva?
BD: Questo è un livello base di umanità condivisa, di accesso universale alla verità, che è in qualche maniera una modalità base per istituire una qualche possibilità di un’esperienza condivisa praticabile, basata sul riconoscimento dello status dell’esperienza soggettiva: riconoscere le sue parzialità con presenza mentale e lavorare verso la ‘imparzialità’. Ciò che si condivide non sono i contenuti dell’esperienza e, meno che mai, le difese del mio personale costrutto identitario, sociale, di genere e così via. Piuttosto, ciò che viene condiviso è lo sforzo di decostruire il modo in cui tutti questi segni del costrutto identitario, in quanto dimensioni dell’individualità sorte in dipendenza, sono stati fabbricati come proprio senso di sé.
Questo è molto, molto importante. Facciamo un esempio pratico: come posso far sorgere la compassione – che deve racchiudere sé e l’altro per essere autentica – in un modo che non sia ‘normativo’ o intenzionale, un’intenzione pia e buona, ma spesso senza speranza? Come può sorgere direttamente da un luogo di genuina trasformazione?
Diciamo, io coltivo i quattro fondamenti della presenza mentale (pali satipaṭṭhāna, sanscrito smṛtyupasthāna). Uno di questi quattro è la contemplazione del corpo (kāya in pali e sanscrito). Questa è la contemplazione della dimensione somatica dell’esperienza soggettiva, così come si dà nel momento presente. Un esercizio di contemplazione del corpo condiviso da tutte le versioni conosciute del Discorso sugli fondamenti della presenza mentale, che coinvolge presenza mentale e indagine dirette ai quattro elementi che compongono questa dimensione somatica, attraverso le qualità elementari della mia esperienza somatica incarnata. Questi sono terra, acqua, fuoco e vento.
Nel buddhismo antico, queste sono qualità che rappresentano l’esperienza della solidità o dell’inerzia (terra), della coesione (acqua), del calore o della temperatura (fuoco) e del movimento (vento). L’idea di base è esaminare questo stesso corpo attraverso gli elementi, riconoscendo: ‘In questo corpo ci sono l’elemento terra, l’elemento acqua, l’elemento fuoco e l’elemento vento’. Gradualmente, si arriva a vedere che la forma o materia (l’aspetto somatico) può diventare un oggetto di esperienza o di cognizione solo nella misura in cui può essere percepita. Perciò, non c’è esperienza soggettiva della forma corporea indipendente da una percezione della forma. Anche il più basilare costituente dell’esperienza, la materialità, può essere esperito solo in presenza di una struttura concettuale, vale a dire la percezione, la percezione della forma corporea. La percezione somatica è un processo sorto in dipendenza, che implica la presenza delle qualità elementari e l’attivazione della componente concettuale nella mente, la quale fa sì che diventino aspetti della mia esperienza.
Qui comprendo, ad esempio, la condizionalità dell’esperienza della durezza dell’elemento terra nel mio corpo. Comprendo che è un fenomeno condizionato, per cui devo avere un corpo e una percezione di esso perché quella sia un’esperienza soggettivamente rilevante. Lo stesso vale per la mia percezione dell’elemento vento. Ci devono essere una controparte fisica ed una riconoscimento concettuale che percepisce questa controparte fisica o somatica. Perciò, si dà sempre questo aspetto della forma o della materia o della corporeità, l’aspetto somatico dell’esperienza, sorto in dipendenza e della percezione che si ha del sorgere di questo corpo o di questa incarnazione nel momento presente.
Mentre pratico internamente-esternamente, internamente ed esternamente, secondo le istruzioni della contemplazione satipaṭṭhāna, pervengo alla comprensione di una sorta di omogeneità tra interno, esterno e interno-e-esterno. C’è continuità e comunanza tra questa esperienza del modo in cui costruisco la mia incarnazione, la mia esperienza della mia propria incarnazione, e il modo in cui gli altri costruiscono la loro esperienza della propria incarnazione. Questo è il nostro punto d’incontro. Questo il luogo dove possiamo incontrarci. Qui può sorgere la compassione, dalla fondamentale visione penetrante della situazione incarnata come qualcosa che ci accomuna, piuttosto che, per dire, da una nobile intenzione o anche da un’ideologia religiosa. Connessione e compassione radicate nella visione penetrante.
BDG: Come si colloca questo in relazione ai temi postmoderni di cui abbiamo discusso?
BD: Dal punto di vista del buddhismo antico, è chiaro che il fondamento per l’autentica compassione e per un giudizio etico, come pure per la scelta di come agire, viene intaccato una volta messa in discussione la possibilità di comprendere le leggi universali dell’esperienza vissuta (in opposizione ai ‘contenuti’) attraverso la saggezza.
La mia compassione sarà sempre solo parziale se non c’è la possibilità di una visione penetrante della realtà universale dell’esistenza umana, che, certo, abbraccia i particolari individuali dell’esperienza, ma non è esclusiva o circoscritta ad essi. E, per definizione, l’intenzione della compassione non è discriminante. Secondo i discorsi antichi, la compassione si irradia in ogni direzione, abbracciando sia la persona che la irradia sia tutti gli altri.
Posso irradiare una sincera compassione in modo imparziale, senza aver bisogno di aver sperimentato personalmente ogni singolo aspetto dell’esperienza di altri esseri afflitti dal dolore e dalla sofferenza. Posso provare compassione e rispondere compassionevolmente con l’azione appropriata, quando richiesto. Seguendo la teoria postmoderna dello standpoint, questo non potrebbe funzionare affatto, sarebbe semplicemente impossibile. Quindi anche la prospettiva di un’azione volta alla giustizia sociale o di un lavoro per l’uguaglianza/equità che siano autenticamente pervasi da una motivazione compassionevole cadrebbe a pezzi.
All’interno della cornice del buddhismo antico, invece, questo è il nostro approccio alla soggettività radicato nell’esperienza in prima persona, in virtù del quale possiamo avere un terreno di condivisione proprio in questa indagine sul modo in cui l’esperienza è costruita. Quindi c’è sicuramente la possibilità, e la necessità, di includere l’esperienza in prima persona, inclusa la soggettività, perché quello che stiamo cercando di capire è come nasce la soggettività; ma non c’è assolutamente alcuna volontà di affermare gli aspetti parziali, gli aspetti condizionati e I punti di vista che su questi sono sorti in dipendenza, basati su vari tipi di condizioni. La miriade di condizionamenti psicologici, culturali, intellettuali e ideologici che formano e pervadono l’esperienza soggettiva non sono più indagati come validi punti di vista epistemici, per la verità.
BDG: Questo in qualche modo è in contrasto con l’estremo postmoderno di mettere in primo piano l’esperienza con una modalità che in qualche modo taglia i ponti tra il mio sé o i sé di coloro che condividono qualche affinità con me e il sé più ampio degli altri?
BD: Sì, questo è la mia posizione. Penso che questo sia un aspetto che può davvero aiutare a collocare in una diversa prospettiva la fascinazione che troviamo a volte nei circoli buddhisti verso questa estrema riprogettazione della soggettività.
Teniamo presente la disconnessione epistemica di cui soffrono intere società. Non solo ci sono un milione di visioni e opinioni diverse, come del resto è sempre stato, ma c’è anche un profondo sgretolamento attorno ciò che costituisce la conoscenza legittima o illegittima. Una volta, avevamo diritto alle nostre proprie opinioni ma non ai nostri personali dati di fatto. Ora, abbiamo diritto anche ai nostri personali dati di fatto. Non si tratta più di una discussione su opinioni o punti di vista diversi, ma ciò che viene messo in discussione sono dati oggettivi di fatto, in nome dell’esperienza profonda che il soggetto ha di tali dati e del rapporto con essi.
Secondo quanto riferito, il Buddha ritenne possibile parlare da una posizione di ‘verifica dei fatti’, per così dire. In che senso verifica dei fatti? Verifica del conoscibile, evidenza concreta della presenza o dell’assenza nella mia esperienza presente delle contaminazioni radice della brama e dell’ignoranza, o dell’avidità, dell’avversione e dell’illusione. Posso fare una verifica fattuale del luogo interiore da cui incontro il mondo. Questo innalza il criterio di valutazione della verità ad un livello molto più alto dell’aspetto meramente teorico della verità. L’enfasi non si pone sui contenuti o sui concetti, ma sulla modalità della conoscenza, sulla trasformazione personale nella direzione di una soggettività imparziale. Quindi, l’orientamento soteriologico è essenziale.
Per concludere, riguardo agli insegnamenti del Buddha, dovremmo pensare ad una conoscenza trasformativa piuttosto che informativa o nozionistica, orientata al contenuto. Quanto trasmesso attorno all’intuizione e alla penetrazione della propria esperienza soggettiva da parte del Buddha, e del suo insegnare un sentiero di pratica che consenta agli altri di valutare la propria esperienza soggettiva, si basa sulla radicale trasformazione delle proprie contaminazioni di brama e ignoranza, che furono sradicate col pieno risveglio.
Questa enfasi posta sul trovare un terreno legittimo per la verità, radicata nella trasformazione personale e orientata alla libertà interiore è l’opposto dei presupposti delle teorie dello standpoint. Questo è uno dei contributi più significativi che il pensiero del buddhismo antico ha da offrire ad una educazione fondata sulla saggezza.
Come già ho detto all’inizio della nostra conversazione, la conoscenza di cui parlo è soteriologica, in tutto e per tutto rilevante ed orientata soteriologicamente.
In definitiva, anche questa conoscenza legittima e valida è subordinata all’abbandono di tutte le posizioni assunte sulle proprie esperienze, punti di vista, percezioni, cognizioni, ecc. In uno degli antichi discorsi, il principale discepolo del Buddha, Sāriputta, spiega infatti che porre fine al dukkha (pali; sanscrito duḥkha) non è qualcosa che accade semplicemente per mezzo della conoscenza (o per mezzo di una condotta etica o in virtù di entrambe). Tuttavia, chi manca di conoscenza o di condotta etica appropriata non sarà in grado di porre fine al dukkha. C’è bisogno di entrambe per giungere fino al punto in cui può verificarsi la svolta verso il risveglio. Questo richiede che si lasci andare completamente tutto ciò che consideriamo essere ‘io’, ‘me’, ‘me stessa’ e ‘mio’. Aggrapparsi a questi ultimi ostacola la svolta liberatrice che porta alla cessazione di ogni fascinazione nei confronti dell’esperienza. Perciò, la soluzione finale, la mossa finale, parte da una salutare conoscenza trasformativa del modo in cui l’esperienza condizionata è costruita per arrivare al non aggrapparsi a quella stessa conoscenza, rinunciando ad essa senza appropriarsene ulteriormente in modo autoreferenziale.
Alla fine, si tratta di riconoscere con presenza mentale quanto l’avidità, l’avversione e l’illusione siano ancora dormienti o attivi in me. È queste stesso atto di autenticità e di verità ad essere trasformativo qui ed ora, ed esso getta le basi per arrivare eventualmente alla completa trasformazione interiore, alla libertà e alla verità con il pieno risveglio, scombinando la costruzione dell’ego (un altro nome del costrutti identitario) nel nostro mondo interno ed esterno.